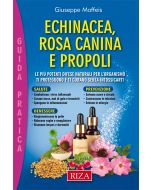Gli additivi chimici possono causare problemi alla salute. Impariamo a riconoscerli dalle etichette dei cibi
La conservazione dei cibi ebbe inizio quando l'uomo imparò a immagazzinare i raccolti e a usare salatura e affumicamento per far durare più a lungo carne e pesce. Oggi la conservazione richiede, nella gran parte dei casi, l'impiego di additivi chimici per conservare o "migliorare" il prodotto. Ma servono davvero?
Leggi anche: Tutto sulla conservazione dei cibi
Gli additivi chimici creano qualche preoccupazione al consumatore consapevole perché, sommati tra loro nel corso dei pasti quotidiani, diventano responsabili dell'aumento del 5% delle allergie alimentari. Non solo. I nitrati e nitriti di sodio e potassio, contenuti nelle carni conservate e nei salumi, possono modificare il funzionamento della tiroide o trasformarsi in composti cancerogeni. I solfiti, presenti in crostacei, vino, frutta secca e candita, funghi secchi, possono causare asma e orticaria. I fosfati di budini, gelati, latte concentrato, prosciutto cotto, possono determinare osteoporosi. Ecco perché è bene scegliere i prodotti che contengono meno additivi chimici o che addirittura non ne possiedono.
Un tempo gli alimenti deperibili potevano essere messi in salamoia, sotto sale, sott'olio, sott'aceto, sotto il grasso, essiccati oppure affumicati. Sono sistemi di conservazione degli alimenti utilizzati da millenni, che continuano a essere validi e che hanno permesso all'uomo di sopravvivere fino a oggi. Ecco quali sono i principali.
Salatura
Viene eseguita ancora oggi con il comune sale da cucina che, disidratando gli alimenti, ostacola lo sviluppo dei germi. Si può effettuare a secco o con salamoia. Il pesce viene solitamente salato a secco e le olive in salamoia.
Essiccazione
È uno dei primi metodi di conservazione. In antichità si otteneva tramite esposizione al sole, oggi è effettuato anche industrialmente mediante l'utilizzo di forni o speciali camere ad aria calda. Viene usata soprattutto per frutta e pesce.
Scottatura
È un trattamento preliminare che viene effettuato con acqua calda o vapore sulla maggior parte dei prodotti vegetali prima che vengano inscatolati o conservati in vasetti di vetro (piselli, fagioli, lenticchie ecc.). In alcuni casi si tratta di una vera e propria cottura (marmellata).
Affumicatura
Il fumo conserva a lungo carni, pesci e alcuni formaggi, oltre a conferire sapori e aromi particolari. Il cibo viene esposto all'azione combinata di calore e fumo sprigionati dalla combustione incompleta di legni come faggio, quercia e castagno.
Sott'olio
L'olio non ha un'azione conservante, serve solo come isolante dall'aria, bloccando l'azione di microrganismi aerobi. È quindi inefficace contro quelli anaerobi (come il botulino) e va sempre associato ad altre forme di conservazione (cottura o salagione).
Sott'aceto
Viene utilizzato soprattutto per conservare gli ortaggi, grazie al suo contenuto in acido acetico, che non deve essere inferiore al 6%. L'azione conservativa è dovuta all'abbassamento del pH e alla tossicità dell'acido acetico nei confronti dei microrganismi.
I prodotti alimentari sono suddivisi in tre gruppi, ovvero quelli che possono essere preparati con più di una classe di additivi chimici, quelli che ne possono contenere soltanto alcuni e quelli che non ne possono contenere affatto. Fra questi ultimi vi sono tutti i prodotti alimentari non lavorati (con poche eccezioni); i surgelati, il miele, l'olio d'oliva, il latte pastorizzato e a lunga conservazione, lo yogurt al naturale, l'acqua minerale, il caffè e il tè, lo zucchero, le paste alimentari secche. In alcuni casi, gli additivi sono costituenti naturali di alcuni alimenti: acido citrico (acidificante e antiossidante), lecitina (emulsionante), pectina (addensante) e vitamine. Vale la pena, infine, ricordare che in questi ultimi anni stanno aumentando notevolmente le aziende che hanno scelto di evitare o di ridurre al minimo l'impiego degli additivi chimici.
Secondo una ricerca dell'Università Politecnica della Catalogna e dell'Università di Barcellona, la cipolla può essere impiegata per ottenere un conservante alimentare naturale, in alternativa ai prodotti simili realizzati artificialmente. Tutto merito dei flavonoidi di questo bulbo.
Le sigle "E" sulle etichette indicano la presenza di additivi chimici approvati dall'Unione Europea (vedi pagine seguenti):
-Antiossidanti: prolungano la durata degli alimenti. Esempio: la vitamina C, chiamata anche acido ascorbico o E300.
-Coloranti: usati per sostituire il colore naturale o per dare un colore adatto. Esempio: il caramello (E150a), presente spesso anche nell'aceto balsamico.
-Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti: le lecitine (E322), per esempio, favoriscono la miscela di ingredienti, come l'olio e l'acqua. Una sostanza gelificante usata comunemente (marmellate) è la pectina (E440).
-Esaltatori di sapidità: esaltano il sapore di alimenti salati e dolci. Esempio: il glutammato monosodico (E621), spesso aggiunto a minestre, salse, salsicce.
-Conservanti: impediscono la deterioramento degli alimenti. Esempi: l'anidride solforosa (E220) per impedire a muffe e batteri di formarsi sulla frutta secca; i nitriti e i nitrati (E249-E252) per carni e salumi.
-Dolcificanti: usati al posto dello zucchero in bibite, yogurt e gomma da masticare. Esempi: aspartame (E951), saccarina (E954) e acesulfame-K (E950).
Le più potenti difese naturali per l’organismo, ti proteggono e ti curano senza intossicarti
Lo zucchero raffinato è responsabile delle più gravi malattie di questo secolo. Ecco come sostituirlo. Proteggi la tua salute